Un progra mma davvero stimolante quello della prima edizione della Rassegna di Cinema Giapponese a Firenze promossa dall’associazione culturale Tokaghe insieme ad una serie di partners e sponsor tra Italia e Giappone; come abbiamo avuto già modo di scrivere, stimolo recepito dalla sorprendente affluenza di pubblico, oltre 8000 presenze complessive in soli 4 giorni di programmazione, un segnale che mette un’ipoteca del tutto positiva sulla crescita futura del festival. Il comitato esecutivo dell’evento, coordinato da Takaaki Matsumoto ha messo insieme uno scambio fecondo tra cinema ed eventi collaterali, strani attrattori capaci di generare una serie di feedback positivi sulle presenze in sala. La direzione artistica di Daniela Raddi (suoi alcuni contenuti Extra dedicati al cinema Giapponese per Rarovideo, i saggi su Imamura, Oshima, Yoshida pubblicati per Università di Tokyo e Istituto di Cultura Giapponese di Roma) è riuscita nell’intento di mettere insieme una selezione costituita da un mix-up di stili e tendenze legate ad una visionarietà tutta contemporanea e non banale dell’immaginario Giapponese; tra il mercato e l’equilibrio autoriale dei film di Yôjirô Takita (di cui abbiamo parlato da questa parte) e le forme di un cinema pop non riconciliato e assolutamente non conciliante si è potuto vedere il sorprendente e doloroso Butagaita Kyoushitsu di Tetsu Maeda, film positivamente sbilanciato tra documentario e commedia per adolescenti che affronta un tema complesso come quello delle attitudini alimentari di un’intera società ridotta in termini di rappresentazione al microcosmo di un’aula scolastica; tra spinta vegana ed esperimento educativo il film si sviluppa come una crudele e progressiva educazione alla presenza della morte. Immagine dell’ambiguità che attraversa tutto l’assetto del divertentissimo The
mma davvero stimolante quello della prima edizione della Rassegna di Cinema Giapponese a Firenze promossa dall’associazione culturale Tokaghe insieme ad una serie di partners e sponsor tra Italia e Giappone; come abbiamo avuto già modo di scrivere, stimolo recepito dalla sorprendente affluenza di pubblico, oltre 8000 presenze complessive in soli 4 giorni di programmazione, un segnale che mette un’ipoteca del tutto positiva sulla crescita futura del festival. Il comitato esecutivo dell’evento, coordinato da Takaaki Matsumoto ha messo insieme uno scambio fecondo tra cinema ed eventi collaterali, strani attrattori capaci di generare una serie di feedback positivi sulle presenze in sala. La direzione artistica di Daniela Raddi (suoi alcuni contenuti Extra dedicati al cinema Giapponese per Rarovideo, i saggi su Imamura, Oshima, Yoshida pubblicati per Università di Tokyo e Istituto di Cultura Giapponese di Roma) è riuscita nell’intento di mettere insieme una selezione costituita da un mix-up di stili e tendenze legate ad una visionarietà tutta contemporanea e non banale dell’immaginario Giapponese; tra il mercato e l’equilibrio autoriale dei film di Yôjirô Takita (di cui abbiamo parlato da questa parte) e le forme di un cinema pop non riconciliato e assolutamente non conciliante si è potuto vedere il sorprendente e doloroso Butagaita Kyoushitsu di Tetsu Maeda, film positivamente sbilanciato tra documentario e commedia per adolescenti che affronta un tema complesso come quello delle attitudini alimentari di un’intera società ridotta in termini di rappresentazione al microcosmo di un’aula scolastica; tra spinta vegana ed esperimento educativo il film si sviluppa come una crudele e progressiva educazione alla presenza della morte. Immagine dell’ambiguità che attraversa tutto l’assetto del divertentissimo The  Magic Hour di Koki Mitani; una rutilante commedia di irriverenza cinematografica che gioca con i topoi della metanarrazione senza farsi risucchiare da uno sterile omaggio alla magia del cinema; al contrario vomita sul set colate di vetriolo in un gioco al massacro capace di cortocircuitare tradizione orientale e icone occidentali; quasi al pari degli ultimi film di Kitano, il film di Mitani fa a brandelli il soggetto e si concentra sulla progressiva distruzione del set; davvero un esempio molto alto di cinema “libero”. Persino la confezione “format” di Wanko The movie, il collage di bizzarie canine messo insieme dalla sintesi di un programma televisivo prodotto dalla Fuji Television, ci ha sorpreso molto positivamente; il film è un mix scollegatissimo e sgangherato di situazioni e gag dalla durata variabile, in mezzo ad una commozione programmata e guidata dalla voce narrante di
Magic Hour di Koki Mitani; una rutilante commedia di irriverenza cinematografica che gioca con i topoi della metanarrazione senza farsi risucchiare da uno sterile omaggio alla magia del cinema; al contrario vomita sul set colate di vetriolo in un gioco al massacro capace di cortocircuitare tradizione orientale e icone occidentali; quasi al pari degli ultimi film di Kitano, il film di Mitani fa a brandelli il soggetto e si concentra sulla progressiva distruzione del set; davvero un esempio molto alto di cinema “libero”. Persino la confezione “format” di Wanko The movie, il collage di bizzarie canine messo insieme dalla sintesi di un programma televisivo prodotto dalla Fuji Television, ci ha sorpreso molto positivamente; il film è un mix scollegatissimo e sgangherato di situazioni e gag dalla durata variabile, in mezzo ad una commozione programmata e guidata dalla voce narrante di 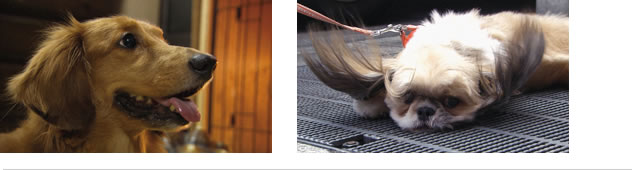 Ryoko Hirosue, vengono fuori i numeri più sintetici e surreali, vere e proprie mostruosità dalla qualità astratta che si affidano alla forza libera e poetica dell’immagine documentaria, qualcosa che se fossimo costretti a descrivere in forma comprensibile e d’effetto, suonerebbe come “l’anti-paperissima”. I due film d’animazione scelti per la rassegna, al di là del già noto Tonari No Totoro, colpiscono per l’innesto di una forte presenza della scrittura nel corpo di una forma pop; i tredici minuti di Tsumiki no ie proiettati nella versione senza voce narrante mettono insieme il tratto delle avanguardie pittoriche Francesi con il movimento sintetico ed iperreale dell’animazione giapponese, due mondi visti in verticale dove quello che potremmo definire come cinema della memoria si realizza soprattutto attraverso l’organizzazione dell’immagine in uno spazio diviso in due, sospesa e visionaria cathédrale engloutie che unisce due tradizioni apparentemente distanti. Il rapporto complesso tra le “nuove onde” storiche del cinema Europeo e la velocità ipertrofica e Cyber dell’ultimo cinema d’animazione Giapponese convivono nel sorprendente Byousoku 5 Cm, il film di Makoto Shinkai che (per una volta almeno) nel suo AKA internazionale trova una sintesi molto precisa dell’universo visivo a cui allude: A Chain of Short Stories About Their Distance; ovvero la persistenza delle increspature e degli interstizi temporali sulla presenza delle storie e di chi le anima; il film di Shinkai è in effetti un vertiginoso saggio sul tempo, che si avvicina in modo non convenzionale alle sconnessioni tra oggetti e spazio che conosciamo attraverso i film di Resnais e quelli di alcuni maestri del cinema Giapponese; tutto questo condotto verso un vortice di segni che vengono assorbiti nella velocità. Ma tra tutti i titoli della rassegna è emerso il cinema illusionistico di Tatsuji Yamazaki; Myaghino è il suo primo lungometraggio, portato a termine dopo quasi cinque anni di lavorazione, un sorprendente esordio che mette insieme tradizione teatrale e pittorica trasmutandole in un’esperienza cinematografica totale, non è solo l’immersione dei personaggi in un decòr desunto dal tratto di Toshusai Sharaku, ma l’artigianato di un cinema che recupera l’infinitesimamente piccolo dei modellini in scala nel passaggio tra arti figurative, gioco e Cinema, set come mondo di possibilità capace di unire impercettibilmente una tradizione secolare alla libertà inventiva dello sguardo che attraversa tutte le avanguardie storiche del cinema. Un approccio quasi “archeologico” che diventa potentemente inedito e contemporaneo; viene in mente il cinema poetico e visionario di Julio Bressane fatto di corpi e reperti e la capacità di Oshima di trasformare segni grafici e oggetti in una parte pulsante del set; non si tratta ovviamente di una relazione diretta, quanto di una considerazione legata alla radicalità di Myaghino; basta pensare all’utilizzo del Tatebanko, un gioco del periodo Edo che consisteva nel disporre su un piano dalla profondità tridimensionale dei personaggi illustrati. ritagliati per l’occasione; Yamazaki se ne serve per filmare quasi tutti gli esterni e i campi lunghi, una sorta di assorbimento e ricomposizione degli elementi di una tradizione in un esempio potentissimo di Cinema immaginifico; sintesi perfetta di tutto quello che abbiamo potuto vedere in questi 4 giorni di Cinema Giapponese, troppo vitali per essere “veri”.
Ryoko Hirosue, vengono fuori i numeri più sintetici e surreali, vere e proprie mostruosità dalla qualità astratta che si affidano alla forza libera e poetica dell’immagine documentaria, qualcosa che se fossimo costretti a descrivere in forma comprensibile e d’effetto, suonerebbe come “l’anti-paperissima”. I due film d’animazione scelti per la rassegna, al di là del già noto Tonari No Totoro, colpiscono per l’innesto di una forte presenza della scrittura nel corpo di una forma pop; i tredici minuti di Tsumiki no ie proiettati nella versione senza voce narrante mettono insieme il tratto delle avanguardie pittoriche Francesi con il movimento sintetico ed iperreale dell’animazione giapponese, due mondi visti in verticale dove quello che potremmo definire come cinema della memoria si realizza soprattutto attraverso l’organizzazione dell’immagine in uno spazio diviso in due, sospesa e visionaria cathédrale engloutie che unisce due tradizioni apparentemente distanti. Il rapporto complesso tra le “nuove onde” storiche del cinema Europeo e la velocità ipertrofica e Cyber dell’ultimo cinema d’animazione Giapponese convivono nel sorprendente Byousoku 5 Cm, il film di Makoto Shinkai che (per una volta almeno) nel suo AKA internazionale trova una sintesi molto precisa dell’universo visivo a cui allude: A Chain of Short Stories About Their Distance; ovvero la persistenza delle increspature e degli interstizi temporali sulla presenza delle storie e di chi le anima; il film di Shinkai è in effetti un vertiginoso saggio sul tempo, che si avvicina in modo non convenzionale alle sconnessioni tra oggetti e spazio che conosciamo attraverso i film di Resnais e quelli di alcuni maestri del cinema Giapponese; tutto questo condotto verso un vortice di segni che vengono assorbiti nella velocità. Ma tra tutti i titoli della rassegna è emerso il cinema illusionistico di Tatsuji Yamazaki; Myaghino è il suo primo lungometraggio, portato a termine dopo quasi cinque anni di lavorazione, un sorprendente esordio che mette insieme tradizione teatrale e pittorica trasmutandole in un’esperienza cinematografica totale, non è solo l’immersione dei personaggi in un decòr desunto dal tratto di Toshusai Sharaku, ma l’artigianato di un cinema che recupera l’infinitesimamente piccolo dei modellini in scala nel passaggio tra arti figurative, gioco e Cinema, set come mondo di possibilità capace di unire impercettibilmente una tradizione secolare alla libertà inventiva dello sguardo che attraversa tutte le avanguardie storiche del cinema. Un approccio quasi “archeologico” che diventa potentemente inedito e contemporaneo; viene in mente il cinema poetico e visionario di Julio Bressane fatto di corpi e reperti e la capacità di Oshima di trasformare segni grafici e oggetti in una parte pulsante del set; non si tratta ovviamente di una relazione diretta, quanto di una considerazione legata alla radicalità di Myaghino; basta pensare all’utilizzo del Tatebanko, un gioco del periodo Edo che consisteva nel disporre su un piano dalla profondità tridimensionale dei personaggi illustrati. ritagliati per l’occasione; Yamazaki se ne serve per filmare quasi tutti gli esterni e i campi lunghi, una sorta di assorbimento e ricomposizione degli elementi di una tradizione in un esempio potentissimo di Cinema immaginifico; sintesi perfetta di tutto quello che abbiamo potuto vedere in questi 4 giorni di Cinema Giapponese, troppo vitali per essere “veri”.





