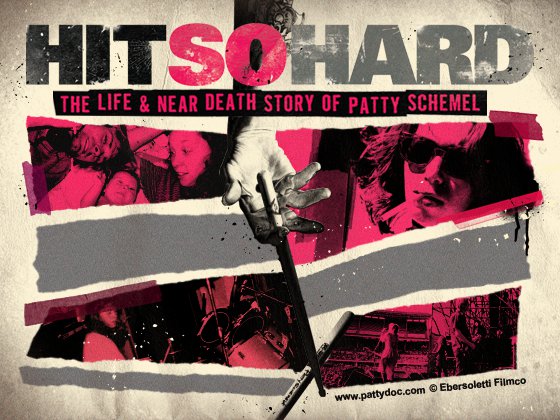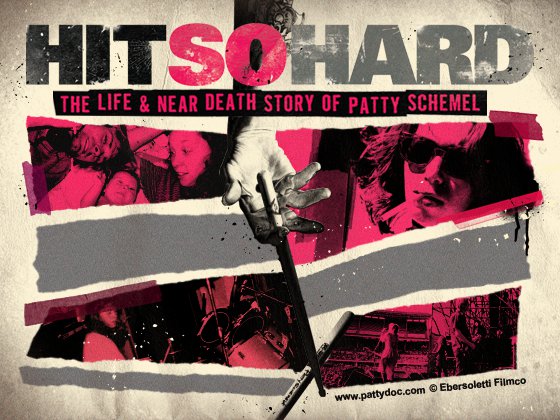“Some people live, some people die. Patty is a survivor” (Eric Erlandson, chitarrista delle Hole).

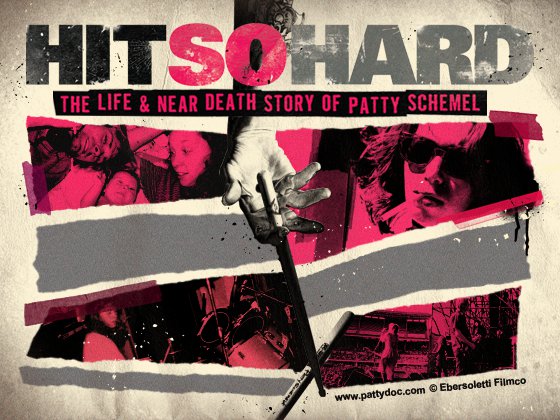 Nel mercato cinematografico contemporaneo i documentari musicali restano forse tra i prodotti più allettanti per i produttori: costano poco e hanno una fetta di pubblico assicurata, quella dei fan, per i quali tra l’altro l’effettiva qualità artistica del prodotto non conta niente. Sulla carta, quindi, questo “Hit So Hard”, biopic di Patty Schemel (batterista delle Hole fino a “Celebrity Skin”), sembrerebbe una banale operazione di mercato: stringere la spugna del movimento grunge, analizzandone un elemento marginale e artisticamente. Il movimento di Seattle è stata una gallina dalle uova d’oro: nei diciassette anni che ormai ci separano dalla morte di Kurt Cobain è stato detto tutto ciò che andava detto, e anche molto di più. Insomma, un film per gli aficionados. E in parte è veramente così. Stupisce, però, come nel tracciato esistenziale di Patty Schemel, lentamente spogliata dalla mitopoiesi intrinseca del genere rockumentary, si individua una parabola generazionale, una fenice che dalle ceneri del movimento resuscita e trova nuova linfa vitale in campagna, tra i cani e gli apprendisti batteristi, lontana dalle luci della ribalta, dalla droga, dal cinismo del music business. Film a tratti noioso e pieno di fuori tema, convenzionale e accattivante quanto basta, “Hit so hard” emerge dalla massa solo per la particolarità del materiale umano rappresentato. Interessante, con qualche sbadiglio.
Nel mercato cinematografico contemporaneo i documentari musicali restano forse tra i prodotti più allettanti per i produttori: costano poco e hanno una fetta di pubblico assicurata, quella dei fan, per i quali tra l’altro l’effettiva qualità artistica del prodotto non conta niente. Sulla carta, quindi, questo “Hit So Hard”, biopic di Patty Schemel (batterista delle Hole fino a “Celebrity Skin”), sembrerebbe una banale operazione di mercato: stringere la spugna del movimento grunge, analizzandone un elemento marginale e artisticamente. Il movimento di Seattle è stata una gallina dalle uova d’oro: nei diciassette anni che ormai ci separano dalla morte di Kurt Cobain è stato detto tutto ciò che andava detto, e anche molto di più. Insomma, un film per gli aficionados. E in parte è veramente così. Stupisce, però, come nel tracciato esistenziale di Patty Schemel, lentamente spogliata dalla mitopoiesi intrinseca del genere rockumentary, si individua una parabola generazionale, una fenice che dalle ceneri del movimento resuscita e trova nuova linfa vitale in campagna, tra i cani e gli apprendisti batteristi, lontana dalle luci della ribalta, dalla droga, dal cinismo del music business. Film a tratti noioso e pieno di fuori tema, convenzionale e accattivante quanto basta, “Hit so hard” emerge dalla massa solo per la particolarità del materiale umano rappresentato. Interessante, con qualche sbadiglio.