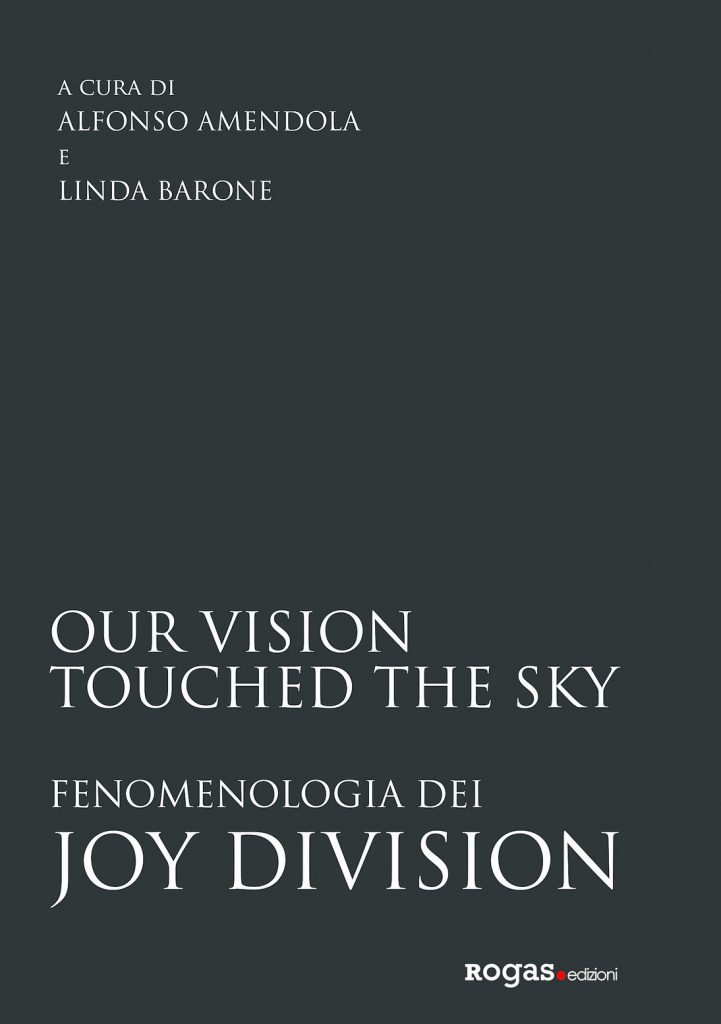Non è il primo né sarà l’ultimo, ma il lavoro connettivo di Alfonso Amendola, professore di sociologia dei processi culturali all’Università di Salerno e di Linda Barone, professoressa di linguistica inglese e traduzione presso lo stesso ateneo, è assolutamente unico nel contesto scientifico italiano. Parte della collana di Scienze di media e Sociologia della cultura, chiamata “La sensibilità Vitale” e diretta dallo stesso Amendola, “Our Vision Touched the sky” attraversa l’opera dei Joy Division con un procedimento interdisciplinare, affrontato mediante una pluralità di prospettive filosofiche, fortunatamente non sempre conciliabili tra di loro e per questo motivo, segno vivo della ricchezza segnica, storica e sociale di quel brodo di coltura in cui sono fermentati i germi del post-punk.
Diviso in quattro sezioni, rispettivamente indicate dai contenitori: Radici, Immaginari, Pensiero e Cartografie in Divenire, il volume è costituito da quasi trecento pagine divise tra più di venti mini saggi che analizzano il ruolo dei Joy Division e la figura di Ian Curtis secondo coordinate legate alla ricerca sociologica, agli elementi grafici e simbolici generati dal loro immaginario, ad altre iconizzazioni simboliche, fino alla titolarità del nome di una band e a tutto quello che è connesso alle tutele come marchio di impresa, nel percorso che dai Joy Division procede verso l’avventura dei New Order, per come viene analizzato nel bel saggio di Giada Iovane e Giovanni Maria Riccio.
Al centro, una psicogeografia possibile, dove si cerca di costruire un ponte tra passato e futuro, nel continuo rimando tra interno ed esterno, città, suono, parola, segno e identità.
In questo senso il lavoro dello stesso Amendola in “Metropoli e spazio periferico nell’underground post punk inglese” dialoga a distanza con quelli di Emiliano Ilardi e Caterina Tomeo, impegnati a tratteggiare i confini della rave era tra suoni e spazi derealizzati, rispettivamente in “Dalla Factory records ai rave nelle factories” e “Tra il sound dei Joy Division e la Rave-Era“, mentre la relazione tra media ed estetica plasma un immaginario che esce dal periodo di riferimento, grazie a successive rimediazioni di istanze subculturali capaci di oltrepassare confini geografici e temporali.
Del resto, tutto il volume curato da Amendola e Barone, nell’intenzione mai celata di una progettualità magmatica e corale, cerca di mettere a fuoco una storia mai scritta del post-punk, come serbatoio ancora inesaurito di creatività, a partire dalla sua genesi storica, per superarla lateralmente e leggerne segni e cicatrici ancora vive.
I segni dicevamo, sono allora molteplici, e tra gli esempi più riusciti di questa gemmazione, il bel saggio di Linda Barone spicca per qualità analitica e capacità combinatorie: “Directionless so plain to see. (Di)Versioni stilistiche, letterarie traduttive” non è solo uno viaggio attraverso il mestiere di traduttore, come continuo (s)radicamento, ma un insieme di comparazioni tra poesia, letteratura e analisi testuale che si muove in forma oscillatoria a partire dai testi di Curtis. Si tratta di un movimento centripeto e centrifugo, un assorbimento rintracciabile nella prassi dello stesso Curtis, ma anche nella rilettura a posteriori delle sue liriche, come sentimento che ispira, genera, crea nuove forme. Dai testi posseduti e amati da Curtis (Ballard, Burroughs, Poe, Lovecraft, Kafka…) alla connessione con la poesia di T.S. Eliot, dove la Barone sistematizza in modo puntuale e preciso una suggestione che, a dire il vero, era già era stata sollecitata da altre intuizioni combinatorie collocate al di fuori del recinto accademico, come per esempio il poco noto mashup tra The Wasteland e Control di Anton Corbijn (n.d.a. piccolo saggio visuale in rete, per gli “ossessionati” come noi, sin dal 2009). La narrativa di Nicholas Royle, Jessie Greengrass, David Gaffney occupa la terza parte del saggio, alla ricerca di una disseminazione verso l’esterno dei testi di Curtis, mentre la sezione conclusiva è un’interessante analisi di alcune parole grammaticali ricorrenti, utilizzate per proporre una dimensione interpretativa differente da quelle più battute.
Alessandro Gnocchi, con identica passione, elabora un possibile percorso Burroughsiano e Ballardiano nei testi di Curtis in “Interzona“, evidenziando i rimandi più o meno evidenti e la mutazione che subiscono nell’elaborazione poetica fatta da Curtis.
Introduce Roberta Paltrinieri, tre pagine densissime dove la responsabile scientifica del DAMSlab dell’università degli studi di Bologna, recupera il Tondelli di Un Week end postmoderno, per definire il post-punk come forma culturale e chiave interpretativa di fenomenologie esterne ed interiori.
Nel bel mezzo di un crepuscolo farmacologico dove il dolore ha irrimediabilmente perso tutta la stratificazione simbolica, questa fenomenologia dei Joy Division, con tutte le contraddizioni interne del caso, è una lettura utile per ridefinire i confini identitari di una comunità senza limiti visibili, che ancora brucia sotto la cenere.
Our Vision touched the sky – Fenomenologia dei Joy Division sul sito di Rogas Edizioni
Our Vision touched the sky – Fenomenologia dei Joy Division – A cura di Alfonso Amendola e Linda Barone
Prefazione: Roberta Paltrinieri
Contributi: Alfonso Amendola, Novella Troianiello, Daniele De Luca, Eugenio Capozzi, Donato Guarino, Alfredo De Sia, Manolo Farci, Paolo Bertetti e Domenico Morreale, Jennifer Malvezzi, Andrea Rabbito, Fabio La Rocca, Alessandro Gnocchi, Vincenzo Romania, Linda Barone, Massimo Villani, Giuseppe Allegri, Fortunato M. Cacciatore, Francesca Ferrara, Caterina Tomeo, Emiliano Ilardi, Raffaele Federici, Giada Iovane, Giovanni Maria Riccio, Michele Grillo.
Editore: Rogas Edizioni
Pagine: 295
Prima Edizione: Marzo 2021
ISBN: 9788899700843
Prezzo: 19,70
Alfonso Amendola è professore di Sociologia dei processi culturali presso l’Università degli Studi di Salerno. Si occupa di sociologia delle arti, dello spettacolo e della letteratura con particolari attenzioni verso le culture d’avanguardia, i consumi di massa, le innovazioni digitali.
Linda Barone è professoressa di Linguistica inglese e Traduzione presso l’Università degli Studi di Salerno. Si occupa di linguistica testuale, multimodalità, didattica della lingua inglese, traduzione letteraria e traduzione audiovisiva.