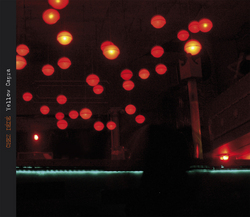 I milanesi Yellow Capra hanno una preparazione strumentale notevole ed è probabilmente quella che gli ha permesso in passato di affrontare con creatività e intelligenza la retorica rischiosa del cosidetto rock cinematico. Senza spalancare porte su un termine che di per se è di scarso interesse, c’è uno scarto impressionante tra quella che, per esempio, è la materia più recente elaborata dai Rachel’s e buona parte dei progetti di musica strumentale prodotti in Italia, intrappolati nello specchio di una riproposizione pedissequa, stanca, poco attenta per esempio, a un patrimonio come quello dei nostri autori di musica per il cinema o a quello che sta facendo dell’immagine sonora un autore come Lim Giong. Cinematico è quindi un parametro vago e anche troppo generoso per Chez Dédé; la seconda release su lunga durata dei Yellow Capra per Piloft recordings presenta una maggiore coesione rispetto a YC al prezzo di perdere una creatività selvaggia che nell’esordio si manifestava all’interno di strutture più libere. L’incipit non è dei migliori, cassavetes si serve di una ritmica furbesca e ben riconoscibile, che con l’innesto del sax ricorda davvero Paul Newman e Sweep the leg johnny, con una propensione quasi prog all’orchestrazione, motore timbrico per ricordi imbarazzanti. Meglio gazebao, echi frippiani e un gioco di intarsi molto bello tra piano e clarinetto. Califoggia è l’episodio che più si avvicina alle intuizioni di YC e in modo molto semplice, si sbarazza degli orpelli postrock per lavorare con le aperture della parte pianistica e la deriva di un mood etnico; questa capacità di rendere il genere un confine assolutamente labile è riproposta ne il mozzicone di morricone, tastiere spinte al massimo della tensione astratta in una risonanza che ricorda quasi un Deodato fuori dal suo contesto sonoro naturale. 20 minuti al buio precipita nuovamente nelle banalità del cinematico per le masse e spiazza con un crescendo finale che da solo riesce a salvare il brano da uno skip senza pietà, grazie anche al valore aggiunto dell’orchestrazione al completo. Se non fosse per quel vago sentore alla Rachel’s prima maniera, ovvero nel solito stagno del post rock superato e che non esiste più, American tafano potrebbe salvarsi grazie al colore mediorientale, approccio visionario che ha un’incidenza solamente residuale su tutto l’ultimo lavoro di Yellow Capra, e che si autorappresenta benissimo nella traccia più irritante di tutto il cd, la lunghissima ed estenuante porco io, disseminazione di piccole impennate geniali, sfuma senza soluzione verso un sopore infinito. Deludente.
I milanesi Yellow Capra hanno una preparazione strumentale notevole ed è probabilmente quella che gli ha permesso in passato di affrontare con creatività e intelligenza la retorica rischiosa del cosidetto rock cinematico. Senza spalancare porte su un termine che di per se è di scarso interesse, c’è uno scarto impressionante tra quella che, per esempio, è la materia più recente elaborata dai Rachel’s e buona parte dei progetti di musica strumentale prodotti in Italia, intrappolati nello specchio di una riproposizione pedissequa, stanca, poco attenta per esempio, a un patrimonio come quello dei nostri autori di musica per il cinema o a quello che sta facendo dell’immagine sonora un autore come Lim Giong. Cinematico è quindi un parametro vago e anche troppo generoso per Chez Dédé; la seconda release su lunga durata dei Yellow Capra per Piloft recordings presenta una maggiore coesione rispetto a YC al prezzo di perdere una creatività selvaggia che nell’esordio si manifestava all’interno di strutture più libere. L’incipit non è dei migliori, cassavetes si serve di una ritmica furbesca e ben riconoscibile, che con l’innesto del sax ricorda davvero Paul Newman e Sweep the leg johnny, con una propensione quasi prog all’orchestrazione, motore timbrico per ricordi imbarazzanti. Meglio gazebao, echi frippiani e un gioco di intarsi molto bello tra piano e clarinetto. Califoggia è l’episodio che più si avvicina alle intuizioni di YC e in modo molto semplice, si sbarazza degli orpelli postrock per lavorare con le aperture della parte pianistica e la deriva di un mood etnico; questa capacità di rendere il genere un confine assolutamente labile è riproposta ne il mozzicone di morricone, tastiere spinte al massimo della tensione astratta in una risonanza che ricorda quasi un Deodato fuori dal suo contesto sonoro naturale. 20 minuti al buio precipita nuovamente nelle banalità del cinematico per le masse e spiazza con un crescendo finale che da solo riesce a salvare il brano da uno skip senza pietà, grazie anche al valore aggiunto dell’orchestrazione al completo. Se non fosse per quel vago sentore alla Rachel’s prima maniera, ovvero nel solito stagno del post rock superato e che non esiste più, American tafano potrebbe salvarsi grazie al colore mediorientale, approccio visionario che ha un’incidenza solamente residuale su tutto l’ultimo lavoro di Yellow Capra, e che si autorappresenta benissimo nella traccia più irritante di tutto il cd, la lunghissima ed estenuante porco io, disseminazione di piccole impennate geniali, sfuma senza soluzione verso un sopore infinito. Deludente.






